


III MODULO - LE INTERFACCE
Connettori per periferiche esterne
Porta Seriale rs-232 (obsoleta)
Lo standard RS-232
nacque nei primi anni sessanta per opera della "Electronic Industries
Association" ed era orientato alla comunicazione tra i mainframe e i
terminali attraverso la linea telefonica, utilizzando un modem.
Oggi la porta seriale RS-232 è presente solo nei vecchi modelli o sui PC
industriali. E' stata soppiantata dall'interfaccia USB in quasi tutti gli
utilizzi. La quasi totalità dei PC oggi non risultano più dotati di questa interfaccia.
Tra gli utilizzi della porta seriale, si possono
citare:
- connessione di terminali ad un calcolatore
(tradizionalmente un mainframe, ma anche un PC)
- connessione di periferiche
- comunicazione tra
due
apparecchiature elettroniche
- la porta seriale è stata usata per collegare i mouse
ai primi PC
- stampante
(soppiantato dalla porta parallela, e poi da USB e dalle stampanti di rete)
- dispositivi specializzati, come ad esempio lettori
di codici a barre e di tessere magnetiche (soppiantato da USB)
- connessione a dispositivi industriali e di rete, per
scopi di configurazione e monitoraggio.
In ambito industriale RS-232 è
ancora ampiamente usato e spesso è necessario dotarsi di un adattatore
seriale/USB per utilizzare come terminale un computer privo di porta seriale.
RS-232 è uno standard costituito da una serie di protocolli fisici, elettrici ed
informatici che rendono possibile lo scambio di informazioni a bassa velocità
tra dispositivi digitali. Esso include
- le caratteristiche elettriche dei
segnali,
- la struttura e le temporizzazioni dei dati seriali,
- la
definizione dei segnali e dei protocolli per il controllo del flusso di dati
seriali su un canale telefonico,
- il connettore e la disposizione dei suoi
pin
- il tipo e la lunghezza massima dei possibili cavi di collegamento.
Nel corso di oltre 40 anni lo
standard si è evoluto, pur mantenendosi in larga parte invariato. L'evoluzione è
riconoscibile dalla sigla, leggendo l'ultima lettera; l'ultima revisione è del
1997 ed è indicata come EIA RS-232f. Probabilmente la versione più diffusa è la
RS232c, del 1969, che corrisponde alle specifiche europee CCITT, raccomandazione
V.24. Pur essendo un protocollo piuttosto vecchio, attualmente la EIA RS-232 è
ancora largamente utilizzata per la comunicazione a bassa velocità tra
microcontrollori, dispositivi industriali ed altri circuiti relativamente
semplici, che non necessitano di particolare velocità; è invece
praticamente scomparsa in ambito "desktop", nel quale lo standard è
stato usato per la
comunicazione tra un computer ed un modem. Esistono due tipologie di connettore:
a 9 pin e 25 pin.
 |
 |
 |
| Porte maschio a 25 e 9 pin sul retro del cabinet | Connettori 9 e 25 pin femmina | |
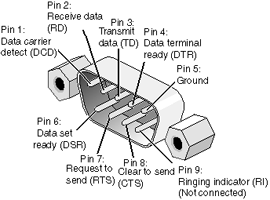

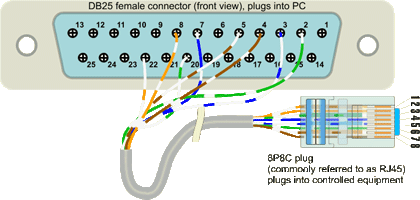
Porta Parallela Centronics (obsoleta)
La porta parallela (detta anche LPT, dall'inglese Line Printer) è un'interfaccia usata inizialmente per collegare un computer a una stampante o a un plotter e in seguito, nella versione bidirezionale, impiegata anche per altre periferiche tra le quali scanner, unità ZIP, hard disk, lettori di CD-ROM e webcam.
 |
||
| Porta parallela femmina a 25 pin |
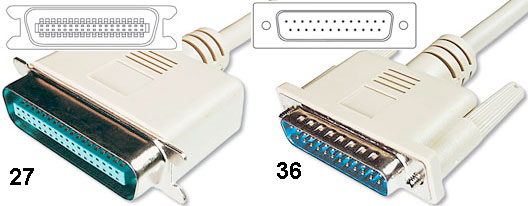 |
| Interfaccia centronics (27) e a 25 pin maschio (36) |
Talvolta, per impedire la copia di software viene usato un dispositivo da collegare alla porta parallela chiamato in vari modi: chiave hardware, "dongle", "hardware token". Il dispositivo non interferisce (o non dovrebbe interferire) con altri usi della porta in quanto "replica" il connettore femmina per collegare altre periferiche e risultare quindi trasparente per i normali utilizzi della porta. È da tempo sostituito con versioni per USB.
Porte USB
L'Universal Serial Bus (USB) è uno standard di comunicazione
seriale che consente di collegare diverse periferiche ad un computer. È stato
progettato per consentire a più periferiche di essere connesse usando una sola
interfaccia (porta) e per migliorare la funzionalità
plug-and-play consentendo di collegare o scollegare i dispositivi senza
dover riavviare il computer (hot swap).
Il sistema USB consiste in un
singolo gestore e molte periferiche collegate da una struttura ad albero
attraverso dei dispositivi chiamati hub (concentratori). Supporta fino ad un
massimo di 127 periferiche per gestore: nel computo vanno però inclusi anche gli
hub e il gestore stesso, quindi, in realtà, il numero totale di dispositivi
collegabili è sensibilmente inferiore. La lunghezza massima che può avere il
cavo senza che il segnale diventi troppo debole è pari a 5 m; oltre questo
limite è necessario ricorrere ad uno o più hub attivi che amplifichino il
segnale. Le specifiche prevedono il collegamento consecutivo al massimo di 5
hub.
Lo standard prevede che il connettore porti anche l'alimentazione
per le periferiche a basso consumo. Le periferiche che hanno richieste
energetiche elevate vanno alimentate a parte. I limiti
energetici dello standard vanno seguiti scrupolosamente pena il probabile
danneggiamento del gestore, dato che lo standard USB non prevede nelle
specifiche minime la sconnessione automatica in caso di sovraccarico.
Il
disegno dell'USB è stato pensato per rendere semplice l'inserimento e
la rimozione. USB può collegare
periferiche quali mouse, tastiere, memoria di massa a stato solido e a disco
rigido, scanner d'immagini, macchine fotografiche digitali, stampanti, casse
acustiche, microfoni e altro ancora.
All'interno del computer, l'USB non
ha rimpiazzato gli standard ATA, SCSI o
serial ATA per via della sua lentezza. Per esempio SATA
consente trasferimenti dell'ordine di 150 Mbyte per
secondo, una velocità molto più elevata dello standard USB,
che nella versione 2.0 raggiunge un massimo di
60
Mbyte per secondo (480 Mbits/s).
L'USB viene invece molto usato
negli hard disk esterni dove si preferisce privilegiare la praticità di poter
collegare e scollegare a caldo il componente rispetto alla velocità.
La versione
USB 3.0 (chiamata SuperSpeed USB) raggiunge la velocità di
600 Mbyte per secondo (4800 Mbits/s).
I primi prodotti commerciali equipaggiati con questo standard sono stati venduti
all'inizio del 2010
Lo standard 1.0 dell'USB (gennaio 1996) supporta
collegamenti a solo 1,5 Mbit/s: velocità adeguata per mouse, tastiere e
dispositivi lenti. La versione 1.1 (settembre 1998) aggiunge la modalità full
speed, che innalza la velocità a 12 Mbit/s.
Lo standard USB versione 2.0
(aprile 2000) ha una
velocità di trasferimento a 480 Mbit/s (60
Mbyte per secondo). Questa velocità
consente all'USB di essere, teoricamente, competitivo con lo standard
Firewire (IEEE 1394) che ha una velocità di trasferimento di 400
Mbits/s (50
Mbyte per secondo), ma agli effetti
pratici quest'ultimo risulti più veloce del primo.
Tipo
Prestazioni
USB 1.0
1,5 Mbit/s (192 KB/s)
USB 1.1
12 Mbit/s (1,5 MB/s)
USB 2.0
480 Mbit/s (60 MB/s)
USB 3.0
4,8 Gbit/s (600 MB/s)
Le specifiche
dell'USB stabiliscono due tipi di connettori standard per collegare i dispositivi, il
connettore A e B.




USB standard tipo A (2) e B (1)
maschi
USB
standard tipo A (3) e B (4) femmina
Schema dei fili
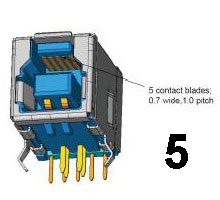 |
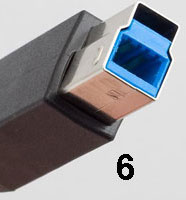 |
 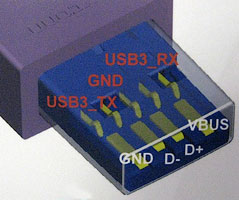 |
|
| USB 3.0 standard tipo B femmina | USB 3.0 standard tipo B maschio | USB 3.0 standard tipo A maschio e schema elettrico |
Negli ultimi
anni alcuni produttori hanno introdotto delle varianti del connettore per i loro
dispositivi miniaturizzati. Molti produttori cercando di ridurre le dimensioni
dei dispositivi hanno deciso di creare connettori più piccoli di quelli
standard. Questi dispositivi rispettano lo standard di comunicazione USB a tutti
gli effetti, l'unica differenza è il connettore che è fisicamente diverso.
I
più diffusi sono: mini USB di tipo
A, B
a 5 poli, mini USB mitsumi
a 4 poli,
micro-USB.



Mini USB A
(5 poli)
abbandonatoMini USB B (5 Poli)
Mini USB Mitsumi
(4 poli)
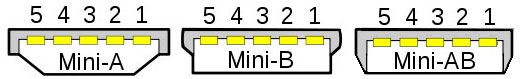



Mini USB A
Femmina - AbbandonatoMini USB B
femmina
-diffuso
Mini USB AB
non diffuso
 |
 |
 |
|
| Micro USB tipo AB | Micro USB tipo B | Micro USB 3.0 Tipo B /td> | |
 |
|||
Il connettore micro USB è stato scelto da alcune delle maggiori aziende di telefonia cellulare del mondo (Nokia, LG, Motorola, Samsung, RIM, Sony Ericsson, NEC, Qualcomm, Texas Instruments) per diventare il connettore standard e dal 2011 sarà presente su tutti i telefoni cellulari del mondo. È stata l'Unione europea a chiederlo al fine di ridurre l'inquinamento elettronico (l'esistenza di decine di caricatori diversi obbliga chi intende cambiare cellulare a buttare via anche il relativo caricabatterie, essendo nella maggior parte dei casi incompatibile con il nuovo telefono). Apple è restia all'introduzione del nuovo connettore, in quanto quello in uso con l'iPod e l'iPhone è protetto da brevetti e l'uso da parte di altre aziende comporta il pagamento ad Apple di salati costi di licenza.

Porta FIREWIRE o IEEE 1394
Il FireWire (o IEEE 1394),
introdotto nel 1995, è di proprietà della Apple Computer. E' conosciuto anche
con il nome commerciale i.Link datogli dalla Sony. Si tratta di
un'interfaccia standard per un bus seriale. Questa interfaccia è in grado di
acquisire dati dagli apparecchi digitali come videocamere e macchine
fotografiche attraverso un flusso continuo in tempo reale.
L'implementazione di Sony di questo standard, nota con il nome di i.Link,
utilizza un connettore con solo 4 pin (ha eliminato i pin dedicati
all'alimentazione) se la videocamera non richiede alimentazione.
La connessione FireWire quindi viene comunemente
usata per collegare dispositivi di archiviazione o dispositivi di acquisizione
video. Punti di forza di questa interfaccia sono:
- banda
elevata
- predisposizione a trattare flussi multimediali,
- possibilità
di stabilire una connessione tra dispositivi senza che un computer faccia da
tramite.
L'interfaccia FireWire è tecnicamente superiore all'interfaccia
USB, ma non è molto diffusa per via dei brevetti. Infatti Apple e altre
ditte richiedono il pagamento di brevetti per ogni implementazione della
FireWire (normalmente 0,25 dollari per l'utente finale). Sebbene le cifre
siano
ridotte, molti produttori realizzano prodotti a bassissimo margine di guadagno e
quindi preferiscono utilizzare la tecnologia USB che, essendo esente dal
pagamento di brevetti, consente loro di ottenere prodotti più economici.
La connessione firewire è di tipo Peer to Peer, quindi ogni apparecchio connesso
può comunicare con l'altro senza bisogno di un host dedicato che guidi la
comunicazione (come ad esempio un computer).
La configurazione avviene
in modo automatico e ad ogni apparecchio viene assegnato un numero
identificativo univoco. Oltre a questo, la firewire è hot pluggable e può quindi
essere connessa o disconnessa in qualsiasi momento senza creare alcun problema.
La firewire supporta 2 differenti modalità di trasferimento dei dati:
- Asincrono:
la modalità di trasferimento asincrono è basata su una
trasmissione di pacchetti ad intervalli di tempo variabile. Questo significa che
l'host invia un pacchetto di dati e aspetta di ricevere una conferma di ricezione
da parte della periferica destinataria. Se l'host riceve la conferma di ricezione, invia il pacchetto di
dati successivo, altrimenti il pacchetto appena spedito viene ritrasmesso dopo un certo tempo di
attesa.
- Isocrono:
la modalità isocrona permette l'invio di
pacchetti di dati di dimensione fissa ad intervalli di tempo regolari. Un nodo,
detto Cycle Master è incaricato di inviare un pacchetto di sincronizzazione
(detto Cycle Start packet) ogni 125 microsecondi. In questo modo non è
necessaria nessuna conferma di ricezione, cosa che permette di garantire una banda
fissa. Inoltre, senza conferma di ricezione,
l'indirizzamento delle periferiche risulta semplificato e la banda passante
risparmiata permette di guadagnare in velocità di trasferimento
 |
 |
 |
 |
| firewire 400 4 pin maschio e femmina (i-link)) | firewire 400 a 6 pin maschio e femmina | ||
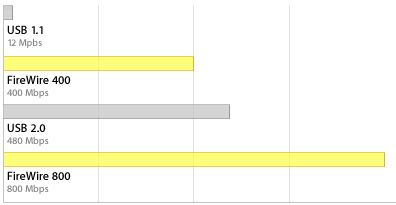
Una successiva implementazione dello standard
firewire venne rilasciata nel 2003 con il nome di Aka FireWire 800
(o IEEE1394b). Questa evoluzione dello standard innalza la velocità della
connessione a 786,432 Mbit/s ed è retrocompatibile col connettore a 6 pin della
FireWire 400.
Le specifiche complete del IEEE 1394b prevedono
anche una connessione ottica lunga fino a 100 metri con una velocità di
trasferimento di 3,2 Gbit/s. L'ampiezza di
banda fornita dalla nuova FireWire 800 è significativamente più veloce dello
standard concorrente USB 2.0.

 &
&
connettore Firewire 800 a 9pin maschio e
femmina
Quasi tutte le moderne telecamere sono dotate di connessione
FireWire, fin dal 1995. La maggior parte delle televisioni digitali e dei box
interattivi in grado di registrare in digitale con lo standard MPEG-2, è dotata
di porta FireWire. Questa interfaccia, adottata per Hard disk esterni, risulta
mediamente più veloce dell'USB./span>
Tra gli altri vantaggi generalmente attribuiti alla tecnologia FireWire
rispetto a quella USB abbiamo:
- maggiore lunghezza dei cavi (fino a 100
metri)
- la possibilità di creare reti P2P in cui le periferiche comunicano
tra loro anche senza un computer
- la capacità di far passare attraverso un
singolo cavo una maggiore quantità di energia elettrica, rendendo quasi sempre
superfluo l'utilizzo di alimentatori esterni (caratteristica particolarmente
utile nel caso degli hard disk esterni).
Nonostante questi vantaggi, FireWire è rimasta una tecnologia di nicchia,
diffusa soprattutto nel settore dei dispositivi audio/video (videocamere,
televisori, set-top box ecc.) e negli hard disk esterni più costosi. Un settore,
quest'ultimo, dove IEEE 1394 deve per altro affrontare l'avversario eSATA,
capace di sfruttare l'interfaccia SATA già presente su tutti i PC e Mac.
Porta
E-sataL'External SATA (abbreviazione
dell'inglese "External Serial Advanced Technology Attachment"), in sigla
eSATA, è un'interfaccia standard utilizzata per connettere dispositivi esterni
(ad esempio gli hard disk esterni), più veloce ed efficiente rispetto all'USB
2.0 e al Firewire, che può arrivare ad una velocità di
3 Gigabit per secondo (Gbit/s) ma è inferiore all'USB 3.0
che invece può
arrivare ad una velocità di 4.8 Gigabit per secondo (Gbit/s) .
Ottima
soluzione per applicazioni che richiedono un elevato trasferimento di dati da e
verso periferiche esterne, come per esempio il video editing e il DVD authoring,
specialmente se in alta definizione.
Comunemente la
porta eSATA è collegata alla scheda madre attraverso un normale cavo Serial ATA:
quindi la velocità di trasmissione dati non varia da eSATA a SATA.
Esistono dei veri e propri adattatori da USB ad eSATA. La praticità di questo
adattatore è evidente, infatti chi possiede un computer datato, oppure
semplicemente non dispone di porte eSATA, può tranquillamente usufruirne
collegandolo ad una normale porta USB.
eSATA è anche un'interfaccia che presenta
un'immunità al rumore, più alta rispetto a SATA, che permette connessioni fino a 2 metri se viene
impiegato un cavo adeguato. Il connettore eSata si presenta senza la tipica
tacca ad "L" dei connettori SATA.
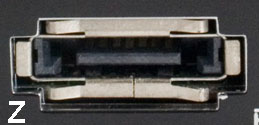 |
 |
| e-SATA femmina | e-SATA maschio |
Porta VGA (obsoleta)
VGA (dall'inglese Video Graphics Array) è uno standard
analogico relativo a display per computer introdotto sul mercato nel 1987 da
IBM.
Il chip VGA può essere installato
direttamente sulla scheda madre di un PC con molta facilità, e già i primi
modelli PS/2 erano equipaggiati col chip VGA sulla scheda madre. Come per molto
dell'hardware IBM, sono stati prodotti dei cloni delle schede grafiche VGA da molti
altri produttori. Nonostante lo standard VGA nella forma originale fosse
considerato obsoleto da tempo, è stato l'ultimo standard IBM che la maggior
parte delle case produttrici decisero di seguire, facendone uno standard grafico
tanto usato da essere ancora presente negli attuali PC. Il VGA è stato
poi ampiamente esteso dalle numerose implementazioni fatte da altre case
produttrici. Queste modifiche fanno ora riferimento allo standard noto come
Super VGA.
Il VGA rimane tutt'oggi un importante
standard grafico. È il "denominatore comune" che tutte le schede grafiche devono
essere in grado di gestire, ancor prima di caricare driver specifico della
scheda. Nelle macchine Windows, lo splash screen che appare all'avvio, mentre la macchina sta lavorando,
è visualizzato
in modalità VGA (non ha ancora
caricato i driver specifici), ed è anche il motivo per il quale la schermata ha
sempre una bassa risoluzione e una profondità di colore limitata.
Intel ha intenzione di terminare il supporto all'interfaccia
VGA nel 2015 nei processori per il settore consumer e nei chipset.


Porta DDVI (obsoleta ma molto diffusa)
La Digital Visual Interface è un apparato hardware in grado di trasmettere del segnale video. Si trova spesso su computer, televisori e videoproiettori che richiedono video ad alta definizione. Attraverso di essa il segnale video viene inviato al monitor in forma digitale, quindi meno soggetta a disturbi.


connettori DVI maschio e femmina
La DVI viene implementata ormai in molte schede video, e porta a un notevole miglioramento rispetto alle precedenti interfacce analogiche. Il connettore DVI può trasportare sia segnali analogici sia digitali, anche contemporaneamente.
 |
Tipologie di segnali supportati dal
connettore DVI/strong> Il connettore DVI può trasportare sia segnali analogici sia digitali, anche contemporaneamente. DVI-A: L'interfaccia DVI-A trasporta esclusivamente segnali analogici in formato compatibile VESA VGA. Qualità e risoluzione max sono identiche a quelle della VGA e cioè consigliata max 1600 × 1200 per monitor LCD, 2048 × 1536 per monitor CRT DVI-D: L'interfaccia DVI-D trasporta esclusivamente segnali digitali. L'interfaccia digitale può essere Single Link o Dual Link. Single Link: L'interfaccia digitale DVI-D Single Link trasporta un massimo di 165 milioni di pixel al secondo utilizzando tre segnali digitali (RGB) a 1,65 Gb/s (10 bit per pixel). La risoluzione standard più alta che può essere visualizzata con questa interfaccia è 1920 × 1200 16:10. Dual Link: Un'interfaccia digitale DVI-D Dual Link affianca al canale utilizzato dall'interfaccia Single Link un secondo canale dati. Questo nuovo canale è implementato sempre con tre segnali digitali (RGB) a 1,65 Gb/s (10 bit per pixel) che operano su 6 pin separati del connettore (quelli centrali). In questo modo è possibile trasportare il doppio dei dati dell'interfaccia Single Link. Questo canale aggiuntivo può essere utilizzato in una tra le due seguenti modalità: - portare un secondo pixel in modo da raddoppiare la risoluzione 2895 × 1882 con un aspect ratio di 16:10 a 60 Hz o 2707 × 2030 con un aspect ratio di 4:3. La risoluzione standard più alta che può essere visualizzata con questa interfaccia è 2560 × 1600 16:10. - aumentare la profondità di colore, che nell'interfaccia Single Link è di 8 bit per pixel (bpp), portandola fino a 16 bpp (in questo caso il secondo canale porta i bit meno significativi). DVI-I: L'interfaccia DVI-I implementa sullo stesso connettore sia i segnali analogici dell'interfaccia DVI-A che quelli digitali dell'interfaccia DVI-D. La parte digitale può essere a un canale o a due canali esattamente come per l'interfaccia DVI-D quindi possiamo avere una DVI-I Single Link o una DVI-I Dual Link a seconda che la parte digitale sia Single Link o Dual Link. |
Esistono limiti relativi all'utilizzo del cavo, ed in
particolare:
- il cavo DVI digitale ha un limite di 5 metri,
superato il
quale la qualità video risulta non più affidabile né garantita; qualora si
intenda aumentare la lunghezza del cavo DVI fino a 30m ed oltre, è necessario
utilizzare opportune apparecchiature atte a compensare la perdita di segnale;
- non è possibile collegare un DVI-A ad un DVI-D poiché DVI-A è solo analogico e
DVI-D è digitale;
- è possibile collegare un'uscita DVI-I o DVI-A ad un
ingresso VGA usando un cavo apposito, poiché inviano segnali analogici;
-- non
è invece possibile collegare direttamente una porta DVI-D ad una VGA poiché
DVI-D usa solo segnali digitali; in questo caso occorre utilizzare un
convertitore DVI per trasformare il segnale da digitale ad analogico e
viceversa.
Il connettore Mini-DVI è
utilizzato da Apple come interfaccia video compatta tesa a sostituire il
connettore Mini-VGA presente sui precedenti notebook. Il connettore
Mini-DVI è
molto più compatto del connettore DVI ma è più grande del connettore μ-DVI
utilizzato dai notebook più piccoli.



Il connettore Mini-DVI è pienamente compatibile
con DVI-I
Single link supportando sia connessioni analogiche che digitali. Questo connettore è stato introdotto
per permettere una connessione ad un monitor esterno (sia analogico che
digitale) anche sui notebook dove le dimensioni di un connettore DVI creano dei
problemi di integrazione./span>
Come detto in precedenza il
connettore Mini-DVI è solamente single link quindi non può essere utilizzato per
risoluzioni video che necessitano di risoluzioni che vanno oltre 1920x1200
@60Hz.
Anche l'interfaccia DVI dovrebbe essere
gradualmente eliminata entro il 2015. Da questo momento ci aspettiamo che
HDMI e DisplayPort - soprattutto quest'ultima
- trovino maggiore supporto e diffusione sia nei monitor che nelle schede madre.
Porta HDMI
HDMI è la sigla che identifica la
High-Definition Multimedia Interface (in italiano, interfaccia multimediale ad
alta definizione)), uno standard commerciale completamente digitale per
l'interfaccia dei segnali audio e video, creato nel 2002 dai principali
produttori di elettronica, tra cui Hitachi, Panasonic, Philips, Sony, Thomson,
Toshiba e Silicon Image..
Lo standard gode anche
dell'appoggio dei principali produttori cinematografici quali Fox, Universal,
Warner Bros e Disney e degli operatori televisivi DirecTV ed EchoStar (DISH
Network), di CableLabs e Samsung..
HDMI è la prima interfaccia
completamente digitale in grado di trasportare contemporaneamente i segnali
audio e video. E' retro-compatibile con l'interfaccia digitale DVI che però è in grado di trasportare solamente il segnale video..
Dal punto di vista della semplicità di utilizzo da
parte di un utente, HDMI ricorda molto la connessione SCART introdotta negli
anni ottanta per collegare le prime videocamere e videoregistratori, utilizzando
un'unica presa per collegare qualsiasi periferica audio/video.. Anche HDMI
può essere utilizzata tra differenti dispositivi audio/video ed è una soluzione
adatta (per quanto non unica) al trasporto del segnale da apparecchi digitali
come lettori DVD e ricevitori satellitari verso schermi anch'essi digitali come
LCD, Plasma o videoproiettori..
A differenza di quanto è avvenuto in
passato con altri tipi di interfacce di collegamento, lo sviluppo
dell'interfaccia HDMI è tutt'altro che completato: uno dei principi base della
nuova interfaccia, fortemente voluto dai produttori, è proprio la sua
caratteristica di essere in costante evoluzione, con ogni nuova versione
identificata con un numero univoco. La prima versione, uscita come detto nel
2002, era la HDMI 1.0. Successivamente, sono arrivati 2 aggiornamenti, 1.1 e
1.2, che hanno progressivamente aumentato la velocità di trasferimento dei dati,
introducendo contemporaneamente altre funzionalità.
Dal punto di vista
dei componenti hardware questa evoluzione non ha cambiato nulla, infatti il cavo e il connettore
sono rimasti invariati, ma è cambiata la gestione software del protocollo di
trasmissione. Grazie a questa serie di aggiornamenti, si è arrivati a quella che
al momento è l'ultima evoluzione di HDMI, ovvero la versione 1.4, datata maggio
2009. Per avere un'idea di quali sono stati i progressi compiuti in soli 4 anni,
basti pensare che mentre HDMI 1.0 era in grado di offrire un bitrate massimo di
4,9 Gb/s, la versione 1.3 arriva fino a 10,2 Gb/s. La versione 1.4 (anno 2009)
include la connessione Ethernet fino a 100 Mbps.
 |
  |
 |
 |
| connettore HDMI | HDMI Maschio (in alto) e femmina (in basso) | HDMI femmina (il primo a sinistra) | convertitore GDMI-DVI-D dlink |
Porta DisplayPort
DisplayPort è uno standard di interfaccia video digitale promosso dalla Video
Electronics Standards Association VESA. Tale standard definisce una tipologia di
connessione audio/video digitale destinata ad essere utilizzata principalmente
nella connessione fra computer e monitor, o fra computer e sistemi Home Theater.
L'interfaccia HDMI continuerà ad essere utilizzata per la connettività con
HDTV
Lo standard, che è disponibile
gratuitamente, è stato pubblicato per la prima volta
nel Maggio 2006; la versione 1.1a è stata
approvata il 2 aprile 2007, mentre la versione attuale 1.2 è stata approvata il
22 dicembre 2009.
DisplayPort supporta una velocità complessiva di 21.6 Gbit/s ed una risoluzione 3840×2400 su cavi di lunghezza fino a 2 metri. Il segnale video non è compatibile con gli standard DVI o HDMI, ma le specifiche consentono comunque il passaggio trasparente dei segnali DVI/HDMI all'interno di questo cablaggio.

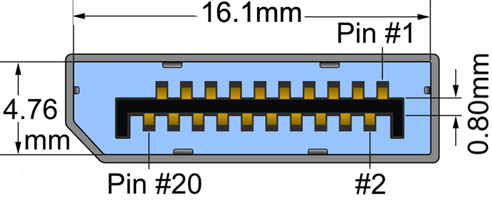
Connettore DisplayPort
schema connettori Displayport
 |
 |
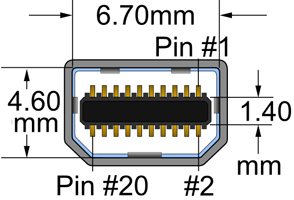 |
| mini displayport femmina e maschio e numerazione connettori | ||
Porta SPDIF
S/PDIF o S/P-DIF è l'acronimo di
Sony/Philips Digital Interface Format (Interfaccia Digitale Sony / Philips).
S/PDIF è coperto dal brevetto EP000000811295B1
L'interfaccia S/PDIF è usata soprattutto nei lettori CD (e i lettori DVD che
riproducono CD), ma è comune anche in altri componenti audio come i MiniDisc e
le schede audio per computer. È utilizzata anche in ambito car-audio, gran parte
del cablaggio può essere sostituito da un unico cavo in fibra ottica immune alle
interferenze elettriche.
A seconda dell'utilizzo le specifiche "S/P-DIF"
consentono l'utilizzo di diversi tipo di cavo. Questi si dividono in connessioni
analogiche (cavi coassiali o RCA) e digitali in fibra ottica (TOSLINK).
Il collegamento ottico è ritenuto più efficace in quanto immune alle
interferenze elettriche.
L'interfaccia S/P-DIF è stata sviluppata a
partire da uno standard rivolto all'audio professionale chiamato AES/EBU
e utilizzato soprattutto nei sistemi Digital Audio
Tape (DAT) e nelle trasmissioni all'interno degli studi di registrazione
professionali. S/P-DIF ha un protocollo di comunicazione pressoché identico, ma
si differenzia a livello fisico per i diversi cablaggi. Questo per rendere S/P-DIF una versione più pratica ed economica del formato
AES/EBU.
L'unica differenza a livello di protocollo tra S/P-DIF e AES/EBU è il "Channel
status bit".
S/P-DIF è adatto alla
trasmissione di dati audio digitali a 20 bit più altre informazioni (per la
protezione dei dati stessi). Nella trasmissione di flussi a meno 20 bit, i bit
superflui avranno valore zero. Alcuni dispositivi utilizzano 4 bit extra per
aumentare la risoluzione a 24 bit (nel caso non siano supportati i bit extra
vengono ignorati).
 |
 |
 |
|
| connettore ottico TOSLINK maschio | e femmina (87A) e
Coassiale femmina (88B) |
Coassiale o RCA maschio |
Porta RJ45 Ethernet
Rappresenta la porta utilizzata per connettere il PC alla rete. Si tratta di un connettore 8 posizioni e 8 contatti (pin) noto con la sigla RJ45. Tale cablaggio consente la connessione a reti locali secondo gli standard Ethernet / IEEE 802.3 10Base-T, 100Base-TX e 1000Base-T.

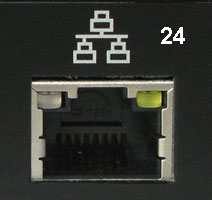
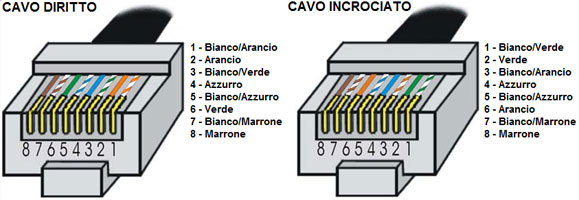
In informatica e telecomunicazioni una Local Area
Network (LAN) (rete in area locale o più semplicemente rete locale in italiano)
è una tipologia di rete informatica contraddistinta da un'estensione
territoriale limitata. L'implementazione classica di LAN è quella che serve
un'abitazione o un'azienda all'interno di un edificio, o al massimo più edifici
adiacenti fra loro (campus).
L'estensione territoriale
limitata di una LAN favorisce la velocità della trasmissione dati, che
inizialmente era tra i 10 Mbps e i 100 Mbps mentre le LAN più recenti operano
poi fino a 10 Gbps. La LAN inoltre, sempre in conseguenza dell'estensione
territoriale limitata, presenta bassi ritardi e pochissimi errori.
Se si escludono le linee di
utenza domestiche si può affermare che le reti LAN sono l'unità minima di base
della rete Internet essendo queste interconnesse tra loro a formare reti
metropolitane (MAN) e poi infine reti geografiche (WAN) dalla cui
interconnessione prende origine Internet stessa. Sotto questo punto di vista le
reti locali, assieme ai loro protocolli, sono classificabili come reti per
l'accesso a Internet.
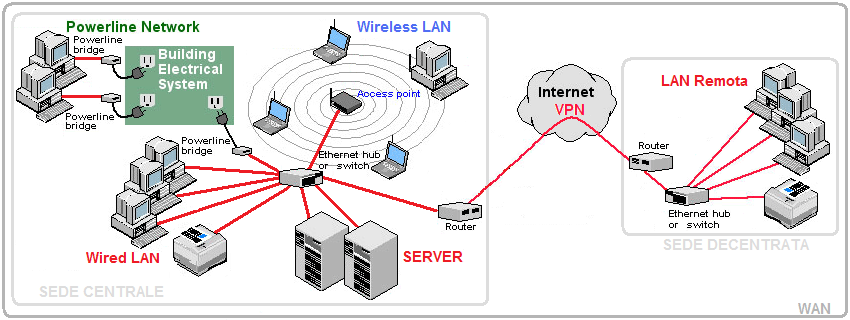
I vantaggi tipici di
una LAN sono:
- condivisione di dati e programmi;
- condivisione di un collegamento a Internet
unico per più PC;
condivisione di accesso a risorse hardware
(stampanti, periferiche fax, modem, etc.);
- riduzione dei costi grazie alla
condivisione;
- standardizzazione delle applicazioni;
- gestione più efficiente di dati,
comunicazione e pianificazioni.
Porta
Wi-FiLa porta Wi-Fi consente l'accesso
wireless ad una LAN. In informatica, wireless local area network
(abbreviato in WLAN o Wireless LAN) indica una “rete locale senza
fili” che sfrutta la tecnologia wireless. Con la sigla WLAN si
indicano genericamente tutte le reti locali di computer che non utilizzano dei
collegamenti via cavo per connettere fra loro gli host della rete.
Le
tipologie di rete wireless sono tre:
- PAN (Personal
Area Network)
- WLAN propriamente dette
- WAN
wireless (Wide Area Network)
Le reti PAN sono composte da collegamenti a
portata ridotta, tipicamente limitata agli oggetti indossati da una persona, o a
quelli contenuti in una automobile. Una tecnologia molto popolare in questo
campo è Bluetooth, e viene usata per abolire i collegamenti fisici (cavi) tra i
dispositivi.
Le LAN aziendali, invece, sono spesso sostituite o integrate
da reti wireless. Questo è vantaggioso negli edifici più vecchi, dove non esiste
o non è possibile installare un impianto di cablaggio strutturato. La tecnologia
WLAN più diffusa è quella basata su specifiche IEEE 802.11 (nota anche con il
nome commerciale Wi-Fi). Ultimamente stanno prendendo piede, invece, le
reti wireless a larga banda e a copertura estesa per le quali è stato sviluppato
lo standard apposito IEEE 802.16 (esempio WiMax).
Le reti wireless possono essere
installate secondo tre modalità strutturali:
- modalità Ad-Hoc:
rende possibile collegare in modo indipendente più postazioni wireless tra loro
senza nessun dispositivo centrale che funga da tramite.
-
modalità infrastruttura (WLAN BSS): si basa su un Access Point
centrale collegato ad una LAN cablata che funge da unico tramite per il traffico
dei dispositivi wireless che si trovano nel range di copertura.
-
modalità estesa (WLAN ESS): si basa sul collegamento tra due o più WLAN
BSS al fine di generare un'area di copertura maggiore. Grazie alla funzione di
roaming, prevista dallo standard IEEE 802.11, un utente della WLAN ESS può
passare da una cella (BSA) all'altra senza risentire di alcuna interruzione del
servizio e quindi in modo totalmente trasparente. È
importante che le celle wireless in configurazione ESS si sovrappongano almeno
del 10% per garantire questa funzionalità.



scheda PCI wireless
Porta IrDA (obsoleta)
IrDA (acronimo in lingua inglese
per Infrared Data Association) identifica un protocollo di comunicazione aperto
(non coperto da brevetti) che fa
uso della radiazione infrarossa per la trasmissione wireless, a breve distanza,
dei dati.
IrDA permette la creazione di reti di tipo PAN ed è uno
standard diffuso globalmente. Era largamente adottato su computer portatili,
palmari, cellulari. Il bluetooth, che è uno standard di
trasmissione radio, ha tuttavia soppiantato la trasmissione a infrarossi.
I dispositivi a infrarossi, per funzionare correttamente,
devono essere posizionati in condizioni di visibilità reciproca (la cosiddetta
LoS, Line of Sight, linea di vista) ad una distanza di 1 o 2 metri. Questi
limiti dipendono dal fatto che la radiazione infrarossa prodotta da questi
dispositivi non è in grado di attraversare muri o altre barriere solide
significative (anche il vetro di una finestra può pregiudicare la qualità della
trasmissione). La velocità di trasmissione più comune è di circa 4 Mbit/s, ma
alcuni dispositivi raggiungono i 16 Mbit/s.



Porta BLUETOOTH
Bluetooth è una specifica industriale per reti
personali senza fili (WPAN: Wireless Personal Area Network). Fornisce un metodo
standard, economico e sicuro per scambiare informazioni tra dispositivi diversi
attraverso una frequenza radio sicura a corto raggio. Bluetooth cerca i
dispositivi entro un raggio di qualche decina di metri. I dispositivi risultano
così
coperti dal segnale che li mette in comunicazione tra di loro. Questi dispositivi
possono essere ad esempio palmari, telefoni cellulari, personal computer,
portatili, stampanti, fotocamere digitali, console per videogiochi.
La specifica Bluetooth è
stata sviluppata da Ericsson e in seguito
formalizzata dalla Bluetooth Special Interest Group (SIG). SIG, la cui
costituzione è stata formalmente annunciata il 20 maggio 1999, è un'associazione
formata da Sony Ericsson, IBM, Intel, Toshiba, Nokia e altre società che si sono
aggiunte come associate o come membri aggiunti.
Il nome è ispirato a
Harald Blåtand (Harold Bluetooth in inglese),
re Aroldo I di Danimarca, abile diplomatico che unì
gli scandinavi introducendo nella regione il
cristianesimo. Gli inventori della tecnologia devono aver ritenuto che fosse un
nome adatto per un protocollo capace di mettere in comunicazione dispositivi
diversi (così come il re unì i popoli della penisola scandinava con la
religione).
Questo standard è stato progettato con l'obiettivo
primario di ottenere bassi consumi, un corto raggio di azione (da 1 a 100 metri)
e un basso costo di produzione per i dispositivi compatibili. Lo standard doveva
consentire il collegamento wireless tra periferiche come stampanti, tastiere,
telefoni, microfoni, ecc. a computer o PDA o tra PDA e PDA.
Attualmente più di un miliardo di dispositivi montano
un'interfaccia Bluetooth.
I telefoni cellulari che integrano chip
Bluetooth sono venduti in milioni di esemplari e sono abilitati a riconoscere e
utilizzare periferiche Bluetooth in modo da svincolarsi dai cavi. BMW è stato il
primo produttore di autoveicoli a integrare tecnologia Bluetooth nelle sue
automobili in modo da consentire ai guidatori di rispondere al proprio telefono
cellulare senza dover staccare le mani dal volante.
Comunque lo standard include anche comunicazioni a
lunga distanza tra dispositivi per realizzare delle LAN wireless.
Ogni dispositivo Bluetooth è in grado di gestire simultaneamente la
comunicazione con altri 7 dispositivi sebbene, essendo un collegamento di tipo
master slave, solo un dispositivo per volta può comunicare con il server. Questa
rete minimale viene chiamata piconet. Le
specifiche Bluetooth consentono di collegare due piconet in modo da espandere la
rete. Tale rete viene chiamata scatternet.
Ogni dispositivo Bluetooth è configurabile per
cercare costantemente altri dispositivi e per collegarsi a questi. Può essere
impostata una password per motivi di sicurezza se lo si ritiene necessario.
Bluetooth non è uno standard comparabile con il Wi-Fi dato che questo è un protocollo nato per fornire elevate velocità di trasmissione con un raggio maggiore, a costo di una maggior potenza dissipata e di un hardware molto più costoso. Infatti il Bluetooth crea una personal area network (PAN) mentre il Wi-FI crea una local area network. Il Bluetooth può essere paragonato al bus USB mentre il Wi-FI può essere paragonato allo standard ethernet.

